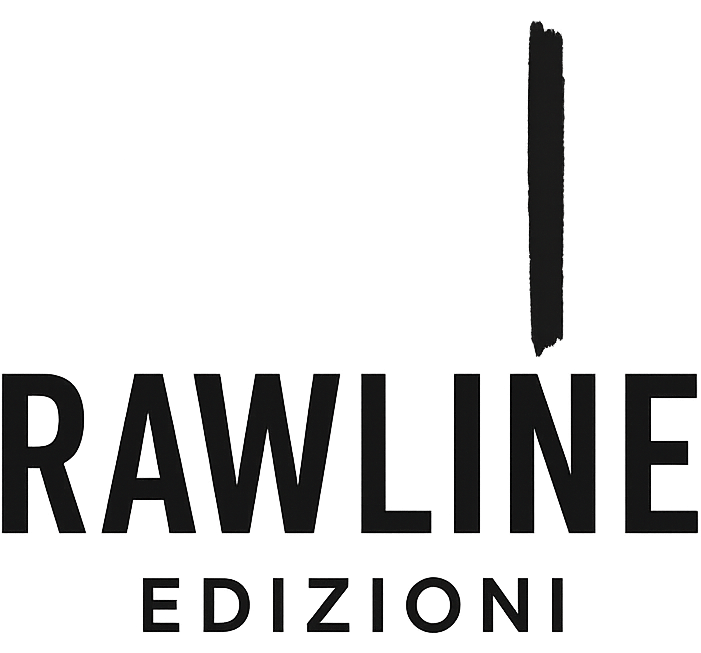Scorri per
leggere il Rawlog
«La scrittura è troppo grezza! Stile è rozzo, irsuto, ruvido, tempestoso!»
Ecco un altro bell’appunto a lato del foglio, scritto in un corsivo color fuoco che solca la carta, con mano decisa, seguito dalla riflessione «Ottimo per screditarlo!»
Certo che la scrittura è grezza. Possono starne sicuri lorsignor maestrini e maestrine dalla penna rossa: nessuno qui vuole prendere il loro posto. Si chiama “scrittura rugged”, ma ci arrivo dopo.
«L’autore è un contadino che non conosce il linguaggio formale.»
Acuti osservatori. Ottima deduzione, bravi.
Però avete sbagliato verbo. Non è “conosce”, ma “apprezza”.
Oltre a non essere un esperto di materia tributaria, non sono nemmeno un giornalista, un letterato, uno scrittore. Sono un Cittadino Medio.
Do you remember? Ed è proprio per questo che posso vedere il vaso di Pandora dall’interno, quel lato grezzo visibile solo chi ci si ritrova dentro.
Tornando al linguaggio formale, non è solo questione di non apprezzarlo. Proprio non lo sopporto, dato che quando viene utilizzato in contesti dove invece c’è da semplificare, genera solo confusione inutile invece di chiarire. Per esempio, nel confronto tra istituzione e un Cittadino.
Attenzione, però. Il “conoscere” non mi è estraneo alla questione: conosco bene il linguaggio formale, purtroppo. Ci convivo ogni giorno, ma dall’altro lato della scrivania, dove siede chi prova a capirci qualcosa per vivere un po’ meglio e con meno frustrazione. È proprio per questo che ho scelto di lasciarlo fuori dalla porta, come si fa con le scarpe sporche.
— Nota di aggiornamento culturale —
Questo stile “grezzo”, ai giorni nostri, ha un nome preciso: si chiama “rugged writing”. Letteratura rugged, quella sulla quale è specializzata e pionieristica la casa editrice con la quale pubblico.
Rugged è una parola sola, in lingua inglese, che significa molte cose: rude, aspro, ma anche robusto, forte, ruvido, rigido, irsuto, tempestoso.
Leggete questo libro con due mani, lasciate il retro della BIC tra i denti così potete farla oscillare su e giù insieme ai pensieri, poi tornate qui e verificate se il testo rispetta tutte le definizioni di cui sopra, raggruppate in quest’unica parola. Rugged.
Cercate sul dizionario, anche on-line. Scorretene l’elenco dei significati. Vi sarà più chiaro perché la Rugged Writing è stata la mia scelta. E, infine, capirete anche perché questo libro non avrebbe potuto essere realizzato senza essa.
Dopotutto, le corrispondenti italiane della parola Rugged non sono forse anche le caratteristiche, le qualità, le attitudini di una persona normale che ne ha le palle piene di un problema sistemico istituzionale e dei conseguenti danni sistematici? Non sono forse i tratti comuni del Cittadino che si presenta allo sportello per avere delucidazioni su un atto giudiziario, la cartella esattoriale, del quale non capisce un cazzo, se non l’importo che deve pagare e la minaccia di pignoramento di beni personali, che sono – invece – specificati in modo molto, moto chiaro?
— Fine della nota di aggiornamento culturale —
Non ci vuole niente a rendere complicato ciò che dovrebbe essere semplice utilizzando un linguaggio formale. Sono capaci tutti di costruire i propri bastioni con mattoni di termini incomprensibili. Non è da “dotti”, ma da stupidi: si vuole trasmettere qualcosa a qualcuno e si rende la cosa impossibile usando un linguaggio che, dall’altra parte, non è – in parte o totalmente – comprensibile.
Prendiamo l’esempio sopra riportato, quella frase «La scrittura è troppo grezza! Stile è rozzo, irsuto, ruvido, tempestoso!»
Con linguaggio tecnico la singolar tenzone si sarebbe medievalmente potuta svolgere così.
Email, 8 Gennaio 2026.
«Alla C.a. gent.le Sign. Vladimiro M. Sansone. Si invita il suddetto soggetto, privo di riconosciute qualificazioni accademiche e/o titoli abilitanti all’elaborazione di contributi in materia tributaria, a fornire costrutti giuridici con modalità espressive proprie, conformi ai canoni di decoro, sobrietà e rispetto istituzionale che la delicatezza dell’argomento trattato — di pertinenza esclusiva di competenze tecnico-specialistiche — inevitabilmente richiede per poter essere gestito adeguatamente tra Cittadino e Stato.»
Risposta. Email, 8 Gennaio 2026, due minuti dopo.
«Egregio Lei, mi spiace ma non sono incline a ottemperare alla Sua richiesta.»
Email, 12 Gennaio 2026.
«Prego?»
Risposta. Email, 12 Gennaio 2026, dopo due minuti.
«Significa “No”. Voglia gradire, nonostante tutto, cordiali saluti. I miei più sentiti ossequi alla Sua signora.»
Meno male che non ho scritto questo libro in tale linguaggio. Non sarebbe stato un dialogo con me stesso, ma con le istituzioni, e questo libro non vuole esserlo in alcun modo. Sarebbe stato fin troppo facile scrivere con lo stesso stile nel quale vengono eretti i muri disfunzionali nelle informazioni burocratiche.
Molto più difficile è mantenere, pensando costantemente a chi legge, i concetti, le spiegazioni, l’apprendimento SEMPLICI e CHIARI, due qualità scritte in maiuscolo in tutto il libro. Caratteristiche che dovrebbero essere intrinseche di ogni informazione fornita sia dalla Pubblica Amministrazione, sia e soprattutto dai funzionari e dirigenti che ne fanno parte.
Peculiarità che dovrebbero avere i testi di semplificazione tecnica, così come ho scelto volontariamente che fosse quello che avete tra le mani.
Come, volutamente, il vostro contadino – che secondo voi non conosce il linguaggio formale – ha deciso di fare.
Altrimenti avrei potuto scrivere:
“Spettabile Apparato Fiscale e Agenzie tutte. In ottemperanza al principio di adeguatezza formale e sostanziale nella comunicazione istituzionale, e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), si rappresenta l’opportunità, per i soggetti in oggetto, di conformare le proprie esternazioni — specie se attinenti a tematiche a elevato coefficiente di tecnicismo settoriale, quelle di natura tributaria — a un lessico coerente sia con la materia trattata, sia e anzitutto con la possibilità di comprensione, grazie a un linguaggio chiaro e accessibile ai Cittadini di qualsiasi tipologia, anche diversamente abili, evitando virtuosismi lessicali, formulazioni giuridiche e termini desueti, obsoleti, arcaici, o inusitati (per es. la parola “Sillabo”, utilizzata da Vs. esimi colleghi operanti presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito) non rispondenti ai canoni di normalità, compostezza ed equilibrio comunicativo previsti dalla vigente etichetta redazionale in ambito pubblico.
In fede, Nino il Contadino.”
«Il testo del libro è troppo parlato, quasi da diario, poco letterario. Non è levigato, urta chi cerca una bella scrittura.»
Allora ci stiamo capendo! Confermo anche questo. E confermo che anche per questo aspetto ci sono motivi – dei “perché” – ben precisi.
Primo perché.
Quello che avete tra le mani è un confronto nel quale sono io, proprio io, quello che ha posto le domande e tratto le proprie conclusioni. E per farlo sono rimasto sempre me stesso. Chi mi conosce lo sa: non ho costruito un personaggio, ho solo approfittato di un gioco di parole che mi diverte per il titolo. Per il resto, non ho finto di essere un burocrate o un fiscalista. Non serve farlo per venirne capo di un problema da pubblica amministrazione, perché lo si guarderebbe dal punto di vista di chi il problema lo ha creato, non di chi lo subisce.
E in ogni caso, sarebbe stato un falso: sono un Cittadino Medio, reale, con la voce di chi ha semplicemente fatto una conversazione sincera. Uno che ha potuto scrivere un testo “provate pure anche voi per verificare se è vero” nel quale non c’è nulla di inventato.
Non c’è trucco, non c’è inganno. Non c’è nemmeno il solito confezionamento editoriale, l’allineamento alle necessità di vendita (perfettamente comprensive e lecite) delle case editrici. Semplicemente, questo testo non è un’operazione commerciale. È un’operazione di sincerismo intellettuale, a partire dal primo punto dell’introduzione, che – lo specifico casomai emergesse qualche appunto di incoerenza dato che il libro ha anch’esso un prezzo, come qualsiasi pubblicazione – ha avuto un costo enorme in termini di tempo, le incidenze economiche di esperienza trentennale non IN materia, ma CON la materia: notti insonni, salute, fatica morale e intellettuale per tenere duro fino all’ultima pagina. È un libro che ha un dimensionamento economico e temporale impossibile da definire all’interno di un’operazione commerciale.
Secondo perché.
Il problema che affronto in questo libro è molto ampio.
Enorme.
Non se ne può arrivare a capo con l’estetica. Si può comprendere con l’etica.
Usare un linguaggio formale, levigato, da saggio tecnico, è esattamente ciò che ha contribuito a generare il problema. Ogni volta che si infila in una pagina un termine tecnico senza spiegarlo, si taglia fuori almeno metà delle persone che stanno cercando di capire. Si diventa attuatori del paradosso di Zenone di Elea, Achille e la Tartaruga: a ogni passo si dimezza la comprensione, e alla fine della gara non ci arriva mai un cazzo di nessuno. Né Achille, né la tartaruga. Come con i documenti dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, di ogni istituzione della PA, di ogni istituto e sistema bancario. Su la mano chi li ha letti almeno una volta da cima a fondo, dalla prima all’ultima parola, comprendendo perfettamente tutto ciò che stava firmando, senza la sensazione di perdersi nel labirinto del Minotauro.
Nota per l’omino grigio laggiù in fondo alla sala, quello che sta cercando sul Web con lo smartphone informazioni sul paradosso per poter sembrare colto: Zenone di Elea non è un personaggio biblico, anche se il nome, di primo acchito potrebbe farlo pensare a chi non lo conosce. È un filosofo antico della Magna Grecia appartenente alla scuola di pensiero di Elea, città greca dell’antica Lucania, la Basilicata quando era un po’ più estesa. E il suo paradosso viene citato da Aristotele.
Tornando alla scrittura e al conseguente linguaggio del libro, usare dunque parole comuni, modi di dire quotidiani, esempi concreti basati su esperienza vissuta dal collettivo, invece, è ciò che permette di farsi capire davvero.
Faccio un esempio.
Torniamo alla parte dove ho spiegato che l’uso di ChatGPT “non è un problema di affidabilità dell’automobile ma del guidatore”?
È diventato tutto chiaro utilizzando quella metafora quotidiana alla portata di tutti? Se sì, allora avete sperimentato il pieno potere della scrittura grezza del popolo.
Il “volgare del volgo“, si chiamava una volta.
Questo non è quindi un libro nato per fare denuncia agli eruditi. Che bisogno c’è di dire, denunciare, a chi crea un problema, che sta creando un problema?
È tempo buttato via.
È un libro pensato, invece, per i Cittadini “Mio Zio Buon Uomo”, che non parlano il linguaggio del Fisco, quelli che ogni giorno cercano di capirci qualcosa per evitare di affondare.
«I veri maestri riescono a dare una connotazione letteraria alle dissertazioni personali.»
Certo, lo penso anch’io. Così dev’essere, ci mancherebbe. Ammiro molto questo aspetto nelle grandi opere.
Ma io non faccio parte della cerchia dei Magister letterari, sono sempre quello di prima: il Cittadino qualunque, che ha fatto scelte precise per questo testo: non casuali, ma da persona “di tutti i giorni”.
Scelte che servono a mantenere al centro la coerenza, la sincerità, la realtà. Anche con il rischio di sbagliare. Anche con il rischio di deviare.
Anche, insomma, quando c’è la certezza che imboccherai vicoli ciechi e dovrai tornare sui tuoi passi.
Come nella vita normale, del resto. Questo è quello che succede alle persone “di tutti i giorni”, prima di arrivare alla propria, autonoma, comprensione profonda di un problema.
E comunque, ho sempre pensato che la “connotazione letteraria alle dissertazioni personali” è si bella, ma utile solo se serve. Solo se permette di capire meglio, altrimenti è fuffa elegante: belle parole che invece di chiarire, confondono. Nessuna trasmissione dei concetti al lettore, nessun apprendimento da parte di quest’ultimo.
Solo esposizione della propria versata preparazione.
Solo un “far vedere a chi legge che si è uno di quegli esperti di cui parla la gente”. Tanto non si sa mai chi sono di preciso, questi famosi esperti, quindi diventa facile mettersi nella schiera. Ma alla base rimane la scelta di non aver l’intenzione di far recepire.
Basta leggere un qualsiasi trattato burocratico o legale per capire cosa intendo.
Uno a caso.
Nati per ampliare i contenuti dei libri RAWLINE. Capitoli extra, considerazioni, materiale da scaricare, da visionare. A supporto del testo o come aggiunta allo stesso.
Scorri per
leggere il Rawlog
«La scrittura è troppo grezza! Stile è rozzo, irsuto, ruvido, tempestoso!»
Ecco un altro bell’appunto a lato del foglio, scritto in un corsivo color fuoco che solca la carta, con mano decisa, seguito dalla riflessione «Ottimo per screditarlo!»
Certo che la scrittura è grezza. Possono starne sicuri lorsignor maestrini e maestrine dalla penna rossa: nessuno qui vuole prendere il loro posto. Si chiama “scrittura rugged”, ma ci arrivo dopo.
«L’autore è un contadino che non conosce il linguaggio formale.»
Acuti osservatori. Ottima deduzione, bravi.
Però avete sbagliato verbo. Non è “conosce”, ma “apprezza”.
Oltre a non essere un esperto di materia tributaria, non sono nemmeno un giornalista, un letterato, uno scrittore. Sono un Cittadino Medio.
Do you remember? Ed è proprio per questo che posso vedere il vaso di Pandora dall’interno, quel lato grezzo visibile solo chi ci si ritrova dentro.
Tornando al linguaggio formale, non è solo questione di non apprezzarlo. Proprio non lo sopporto, dato che quando viene utilizzato in contesti dove invece c’è da semplificare, genera solo confusione inutile invece di chiarire. Per esempio, nel confronto tra istituzione e un Cittadino.
Attenzione, però. Il “conoscere” non mi è estraneo alla questione: conosco bene il linguaggio formale, purtroppo. Ci convivo ogni giorno, ma dall’altro lato della scrivania, dove siede chi prova a capirci qualcosa per vivere un po’ meglio e con meno frustrazione. È proprio per questo che ho scelto di lasciarlo fuori dalla porta, come si fa con le scarpe sporche.
— Nota di aggiornamento culturale —
Questo stile “grezzo”, ai giorni nostri, ha un nome preciso: si chiama “rugged writing”. Letteratura rugged, quella sulla quale è specializzata e pionieristica la casa editrice con la quale pubblico.
Rugged è una parola sola, in lingua inglese, che significa molte cose: rude, aspro, ma anche robusto, forte, ruvido, rigido, irsuto, tempestoso.
Leggete questo libro con due mani, lasciate il retro della BIC tra i denti così potete farla oscillare su e giù insieme ai pensieri, poi tornate qui e verificate se il testo rispetta tutte le definizioni di cui sopra, raggruppate in quest’unica parola. Rugged.
Cercate sul dizionario, anche on-line. Scorretene l’elenco dei significati. Vi sarà più chiaro perché la Rugged Writing è stata la mia scelta. E, infine, capirete anche perché questo libro non avrebbe potuto essere realizzato senza essa.
Dopotutto, le corrispondenti italiane della parola Rugged non sono forse anche le caratteristiche, le qualità, le attitudini di una persona normale che ne ha le palle piene di un problema sistemico istituzionale e dei conseguenti danni sistematici? Non sono forse i tratti comuni del Cittadino che si presenta allo sportello per avere delucidazioni su un atto giudiziario, la cartella esattoriale, del quale non capisce un cazzo, se non l’importo che deve pagare e la minaccia di pignoramento di beni personali, che sono – invece – specificati in modo molto, moto chiaro?
— Fine della nota di aggiornamento culturale —
Non ci vuole niente a rendere complicato ciò che dovrebbe essere semplice utilizzando un linguaggio formale. Sono capaci tutti di costruire i propri bastioni con mattoni di termini incomprensibili. Non è da “dotti”, ma da stupidi: si vuole trasmettere qualcosa a qualcuno e si rende la cosa impossibile usando un linguaggio che, dall’altra parte, non è – in parte o totalmente – comprensibile.
Prendiamo l’esempio sopra riportato, quella frase «La scrittura è troppo grezza! Stile è rozzo, irsuto, ruvido, tempestoso!»
Con linguaggio tecnico la singolar tenzone si sarebbe medievalmente potuta svolgere così.
Email, 8 Gennaio 2026.
«Alla C.a. gent.le Sign. Vladimiro M. Sansone. Si invita il suddetto soggetto, privo di riconosciute qualificazioni accademiche e/o titoli abilitanti all’elaborazione di contributi in materia tributaria, a fornire costrutti giuridici con modalità espressive proprie, conformi ai canoni di decoro, sobrietà e rispetto istituzionale che la delicatezza dell’argomento trattato — di pertinenza esclusiva di competenze tecnico-specialistiche — inevitabilmente richiede per poter essere gestito adeguatamente tra Cittadino e Stato.»
Risposta. Email, 8 Gennaio 2026, due minuti dopo.
«Egregio Lei, mi spiace ma non sono incline a ottemperare alla Sua richiesta.»
Email, 12 Gennaio 2026.
«Prego?»
Risposta. Email, 12 Gennaio 2026, dopo due minuti.
«Significa “No”. Voglia gradire, nonostante tutto, cordiali saluti. I miei più sentiti ossequi alla Sua signora.»
Meno male che non ho scritto questo libro in tale linguaggio. Non sarebbe stato un dialogo con me stesso, ma con le istituzioni, e questo libro non vuole esserlo in alcun modo. Sarebbe stato fin troppo facile scrivere con lo stesso stile nel quale vengono eretti i muri disfunzionali nelle informazioni burocratiche.
Molto più difficile è mantenere, pensando costantemente a chi legge, i concetti, le spiegazioni, l’apprendimento SEMPLICI e CHIARI, due qualità scritte in maiuscolo in tutto il libro. Caratteristiche che dovrebbero essere intrinseche di ogni informazione fornita sia dalla Pubblica Amministrazione, sia e soprattutto dai funzionari e dirigenti che ne fanno parte.
Peculiarità che dovrebbero avere i testi di semplificazione tecnica, così come ho scelto volontariamente che fosse quello che avete tra le mani.
Come, volutamente, il vostro contadino – che secondo voi non conosce il linguaggio formale – ha deciso di fare.
Altrimenti avrei potuto scrivere:
“Spettabile Apparato Fiscale e Agenzie tutte. In ottemperanza al principio di adeguatezza formale e sostanziale nella comunicazione istituzionale, e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), si rappresenta l’opportunità, per i soggetti in oggetto, di conformare le proprie esternazioni — specie se attinenti a tematiche a elevato coefficiente di tecnicismo settoriale, quelle di natura tributaria — a un lessico coerente sia con la materia trattata, sia e anzitutto con la possibilità di comprensione, grazie a un linguaggio chiaro e accessibile ai Cittadini di qualsiasi tipologia, anche diversamente abili, evitando virtuosismi lessicali, formulazioni giuridiche e termini desueti, obsoleti, arcaici, o inusitati (per es. la parola “Sillabo”, utilizzata da Vs. esimi colleghi operanti presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito) non rispondenti ai canoni di normalità, compostezza ed equilibrio comunicativo previsti dalla vigente etichetta redazionale in ambito pubblico.
In fede, Nino il Contadino.”
«Il testo del libro è troppo parlato, quasi da diario, poco letterario. Non è levigato, urta chi cerca una bella scrittura.»
Allora ci stiamo capendo! Confermo anche questo. E confermo che anche per questo aspetto ci sono motivi – dei “perché” – ben precisi.
Primo perché.
Quello che avete tra le mani è un confronto nel quale sono io, proprio io, quello che ha posto le domande e tratto le proprie conclusioni. E per farlo sono rimasto sempre me stesso. Chi mi conosce lo sa: non ho costruito un personaggio, ho solo approfittato di un gioco di parole che mi diverte per il titolo. Per il resto, non ho finto di essere un burocrate o un fiscalista. Non serve farlo per venirne capo di un problema da pubblica amministrazione, perché lo si guarderebbe dal punto di vista di chi il problema lo ha creato, non di chi lo subisce.
E in ogni caso, sarebbe stato un falso: sono un Cittadino Medio, reale, con la voce di chi ha semplicemente fatto una conversazione sincera. Uno che ha potuto scrivere un testo “provate pure anche voi per verificare se è vero” nel quale non c’è nulla di inventato.
Non c’è trucco, non c’è inganno. Non c’è nemmeno il solito confezionamento editoriale, l’allineamento alle necessità di vendita (perfettamente comprensive e lecite) delle case editrici. Semplicemente, questo testo non è un’operazione commerciale. È un’operazione di sincerismo intellettuale, a partire dal primo punto dell’introduzione, che – lo specifico casomai emergesse qualche appunto di incoerenza dato che il libro ha anch’esso un prezzo, come qualsiasi pubblicazione – ha avuto un costo enorme in termini di tempo, le incidenze economiche di esperienza trentennale non IN materia, ma CON la materia: notti insonni, salute, fatica morale e intellettuale per tenere duro fino all’ultima pagina. È un libro che ha un dimensionamento economico e temporale impossibile da definire all’interno di un’operazione commerciale.
Secondo perché.
Il problema che affronto in questo libro è molto ampio.
Enorme.
Non se ne può arrivare a capo con l’estetica. Si può comprendere con l’etica.
Usare un linguaggio formale, levigato, da saggio tecnico, è esattamente ciò che ha contribuito a generare il problema. Ogni volta che si infila in una pagina un termine tecnico senza spiegarlo, si taglia fuori almeno metà delle persone che stanno cercando di capire. Si diventa attuatori del paradosso di Zenone di Elea, Achille e la Tartaruga: a ogni passo si dimezza la comprensione, e alla fine della gara non ci arriva mai un cazzo di nessuno. Né Achille, né la tartaruga. Come con i documenti dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, di ogni istituzione della PA, di ogni istituto e sistema bancario. Su la mano chi li ha letti almeno una volta da cima a fondo, dalla prima all’ultima parola, comprendendo perfettamente tutto ciò che stava firmando, senza la sensazione di perdersi nel labirinto del Minotauro.
Nota per l’omino grigio laggiù in fondo alla sala, quello che sta cercando sul Web con lo smartphone informazioni sul paradosso per poter sembrare colto: Zenone di Elea non è un personaggio biblico, anche se il nome, di primo acchito potrebbe farlo pensare a chi non lo conosce. È un filosofo antico della Magna Grecia appartenente alla scuola di pensiero di Elea, città greca dell’antica Lucania, la Basilicata quando era un po’ più estesa. E il suo paradosso viene citato da Aristotele.
Tornando alla scrittura e al conseguente linguaggio del libro, usare dunque parole comuni, modi di dire quotidiani, esempi concreti basati su esperienza vissuta dal collettivo, invece, è ciò che permette di farsi capire davvero.
Faccio un esempio.
Torniamo alla parte dove ho spiegato che l’uso di ChatGPT “non è un problema di affidabilità dell’automobile ma del guidatore”?
È diventato tutto chiaro utilizzando quella metafora quotidiana alla portata di tutti? Se sì, allora avete sperimentato il pieno potere della scrittura grezza del popolo.
Il “volgare del volgo“, si chiamava una volta.
Questo non è quindi un libro nato per fare denuncia agli eruditi. Che bisogno c’è di dire, denunciare, a chi crea un problema, che sta creando un problema?
È tempo buttato via.
È un libro pensato, invece, per i Cittadini “Mio Zio Buon Uomo”, che non parlano il linguaggio del Fisco, quelli che ogni giorno cercano di capirci qualcosa per evitare di affondare.
«I veri maestri riescono a dare una connotazione letteraria alle dissertazioni personali.»
Certo, lo penso anch’io. Così dev’essere, ci mancherebbe. Ammiro molto questo aspetto nelle grandi opere.
Ma io non faccio parte della cerchia dei Magister letterari, sono sempre quello di prima: il Cittadino qualunque, che ha fatto scelte precise per questo testo: non casuali, ma da persona “di tutti i giorni”.
Scelte che servono a mantenere al centro la coerenza, la sincerità, la realtà. Anche con il rischio di sbagliare. Anche con il rischio di deviare.
Anche, insomma, quando c’è la certezza che imboccherai vicoli ciechi e dovrai tornare sui tuoi passi.
Come nella vita normale, del resto. Questo è quello che succede alle persone “di tutti i giorni”, prima di arrivare alla propria, autonoma, comprensione profonda di un problema.
E comunque, ho sempre pensato che la “connotazione letteraria alle dissertazioni personali” è si bella, ma utile solo se serve. Solo se permette di capire meglio, altrimenti è fuffa elegante: belle parole che invece di chiarire, confondono. Nessuna trasmissione dei concetti al lettore, nessun apprendimento da parte di quest’ultimo.
Solo esposizione della propria versata preparazione.
Solo un “far vedere a chi legge che si è uno di quegli esperti di cui parla la gente”. Tanto non si sa mai chi sono di preciso, questi famosi esperti, quindi diventa facile mettersi nella schiera. Ma alla base rimane la scelta di non aver l’intenzione di far recepire.
Basta leggere un qualsiasi trattato burocratico o legale per capire cosa intendo.
Uno a caso.